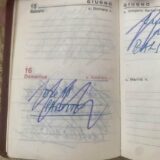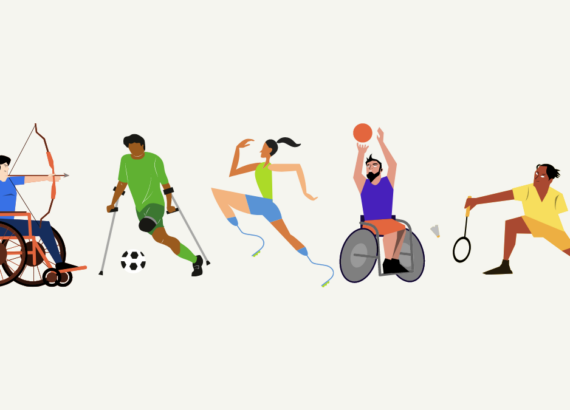il sentimento italiano raccontato da sanremo

Ogni anno arriva il Festival di Sanremo che porta con sé allegria, attese, polemiche e tanto interesse per il mood del momento da rappresentare su quel palco.
Una kermesse musicale che fa parte delle nostre vite e allieta la settimana di febbraio più chiacchierata e discussa dell’anno. Quella manifestazione che nel dopoguerra venne definita come “la grande evasione”, quella colonna sonora di un Paese che sentiva la necessità di leggerezza, di fischiettare al sole e di ritornare a vivere.
Dalla sua prima edizione del 1951 che si tenne nel Salone delle feste del Casinò di Sanremo – quando i cantanti si esibivano davanti a un pubblico seduto intorno ai tavolini del vecchio cafè chantant e la musica si diffondeva nella stanza tra l’andirivieni dei camerieri – il Festival di Sanremo è diventato il prodotto televisivo che oggi conosciamo da migliaia di euro, molto amato, a volte odiato, ma sempre discusso.
Quest’anno non l’ho seguito, ma ne ho assaporato il senso fra le note, i dibattiti dei talk e i commenti delle amiche.
Ho ripercorso, attraverso video e teke RAI, la storia del Festival che ha cambiato vestito attraverso numerosi cambiamenti e piccole e grandi rivoluzioni.
Certo, in 73 anni l’Italia è cambiata, ed è normale che cambino abitudini, parole, mode e vestiti.
Quello che non dovrebbe mai cambiare però è il senso delle cose.
A vincere è stata sempre la canzone italiana, non il cantante. Anche negli sfarzosi anni ’80 – quando l’eccentricità di alcuni interpreti e cantautori, nonché la fama di ospiti stranieri, poteva catturare l’attenzione del pubblico – la canzone dominava su tutto.
Oggi ho l’impressione che la canzone sia, invece, in secondo piano e che prevalga un diffuso disinteresse tra molti addetti ai lavori verso un Festival che tutto celebra fuorché la canzone.
Da Festival della canzone italiana Sanremo dovrebbe cambiare il nome in Festival dei cantanti italiani, perché di fatto questo è: a venire premiati sono solo gli interpreti, raramente veri coautori dei brani che portano in gara, mentre tutti coloro i quali costituiscono la vera colonna portante dell’industria musicale pop italiana non ricevono, oltre alle solite fugaci menzioni, alcun genere di riconoscimento.
Oltre a questo aspetto mi viene da pensare ad un altro cambiamento che deforma il senso di Sanremo, ovvero la trasformazione da Festival della canzone italiana in Festivalbar.
Le melodie vincenti sono belle, indubbiamente, ma scatenano la voglia di ballare, tipica dell’estate e degli happy-hour in costume sulle spiagge. Non riportano a quei sentimenti e aneliti tutti italiani raccontati negli ultimi 70 anni di manifestazione che, appunto, sono sempre stati il senso di Sanremo
Non è un discorso di bigottismo, anzi è il contrario. Io sono per la rivoluzione e l’adeguamento al cambiamento, ma ciò non significa solo divertimento, sesso, storie leggere, parolacce, abiti succinti amori finiti e dimenticati in fretta e individualismo.
Il sentimento italiano raccontato da Sanremo è partito dal dopoguerra con una donna innamorata che ringrazia per i fiori ricevuti, quasi incredula di poter sognare di nuovo l’amore, poi è arrivato a Volare verso un sogno di spensieratezza e di amore (divenendo l’inno indiscusso della canzone italiana nel mondo); quindi ha continuato a parlare sempre d’amore come unica forza della vita, fino agli anni 70, dove si è cominciato ad intravedere anche la contestazione politica dei lavoratori di quel periodo perché si è detto che “Chi non lavora non fa l’amore”, e si è arrivati ai gruppi musicali che hanno sfornato canzoni d’amore miste al sociale, e ai grandi autori che hanno scritto tra le poesie musicali più belle di sempre, lasciando il segno perchè “non sarà un’avventura, questo amore è fatto solo di poesia” .
Poi l’Italia cambiava ancora, e con lei Sanremo, che ne rappresentava i nuovi vestiti attraverso un italiano che dava il buongiorno all’Italia con “un partigiano come Presidente, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne e sempre meno suore”.
Ci ha fatto apprezzare la semplicità dell’amore e la felicità che sta dietro “un panino e un bicchiere di vino”, fino alla consapevolezza che “perdere l’amore, quando si fa sera” può fare tanto male.
Ma i temi sociali non sono mai mancati e hanno tenuto il passo di una società che si stava trasformando e subiva attentati e tangenti. Qualcuno ha detto “Italia si Italia no”; di un papa nero, della diversità di Luca che era gay, delle menti perse alle quali regalare una rosa per dargli una voce mai ricevuta, di droga chiedendo perché lo fai alla propria fidanzata, di mafia con i carabinieri di turno che si rivolgevano al loro “signor tenente” per descrivere un’Italia e una Sicilia attentata e trafitta al cuore.
Sanremo è sempre stato lo specchio dell’Italia, dei suoi cambiamenti, delle sue ferite e delle sue ambizioni. Ed era la canzone a descriverlo, non gli ospiti o i co-conduttori.
Se lo è ancora oggi, quali sono le ambizioni della nostra Italia?
A parte alcuni brani dell’ultima edizione ispirati al femminismo e al dramma dei migranti, il resto parla delle introspezioni interne e dei drammi esistenziali in chiave e ritmo disco Papete!
Probabilmente oggi Sanremo rappresenta l’individualismo che attanaglia la società che ha perso gli ideali.
Non vince la canzone italiana ma il cantante. E il cantante ha poco da dire se non delle proprie personali considerazioni.
Cosa sarebbe la notte degli Oscar se dei film in gara ricevessero un riconoscimento i soli attori?
Cambierebbe i connotati e diventerebbe una manifestazione priva del suo senso che sono i registi, soggettisti, sceneggiatori, direttori della fotografia, montatori, costumisti, ecc., perché ognuno dei migliori protagonisti di quella articolata macchina artistica che è il cinema deve giustamentevivere il proprio momento di gloria, quel momento nel quale il proprio ruolo, la propria figura professionale e dunque la relativa importanza assumono significato agli occhi del grande pubblico. È questo, a ben vedere, il trionfo di una visione collettivista e democratica.
Assistiamo invece al trionfo dell’individualismo, un individualismo, tra le altre cose, assolutamente spostato su soggetti che, nell’economia produttiva del mondo musicale pop, ricoprono un ruolo non certamente più importante di chi, da dietro le quinte, determina successi e glorie altrui.


Intanto 73 anni fa vinceva a Sanremo una donna e quest’anno anche, entrambe talentuose e con voci belle. Una parlava di fiori, che fra tutti gli altri aveva riconosciuto, nonostante l’amore perduto (forse, quindi, non proprio perduto); l’altra di noia e pagine pigre.
Io so quale Sanremo mi rappresenta di più. E voi?
Libera Scirpoli