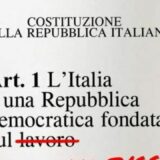LA CAPACITà DI SPESA DELLE REGIONI

LIBERA SCIRPOLI
Uno dei miei studi alla Sapienza ha riguardato le agenzie di sviluppo locale, in particolare ho affrontato lo stato dell’arte dell’agro nocerino sarnese nel 2008.
Oggi, a distanza di tanti anni, mi occupo di finanziamenti e, considerando l’importanza che essi rivestono per le nostre comunità, ritengo sostanziale la redazione di bilanci periodico sullo stato di avanzamento della spesa comunitaria dei programmi gestiti dalle regioni italiane nel ciclo di programmazione comunitaria.
In particolare, si ha la percezione che l’Italia non riceva risorse dall’UE a causa della gestione non sempre efficiente della spesa delle regioni.
Se si considerano esclusivamente i programmi di sviluppo regionali (e non anche quelli nazionali) a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), l’ammontare totale di risorse che le regioni italiane dispongono nel ciclo di programmazione 2014-2020 è pari a 35,5 miliardi di euro. Di questi, 21,2 miliardi (60% circa) sono stanziati direttamente dal budget dell’Unione Europea e 14,3 miliardi provengono dal cofinanziamento nazionale.
Ad oggi, le regioni italiane hanno speso in totale 7,4 miliardi di euro (4,6 miliardi di fondi UE e il resto di fondi nazionali). Questa spesa è pari al 23% della dotazione a disposizione delle regioni. Dagli impegni di spesa, si ricava che le regioni italiane stanno finalizzando interventi per un ammontare complessivo di 25,8 miliardi di euro, cioè il 69% del totale dei vari programmi regionali.
Vista la sequenza logico-temporale che lega i pagamenti agli impegni, è plausibile immaginare che l’attuazione finanziaria dei programmi regionali proseguirà in modo regolare, poiché gli attuali impegni alimenteranno nei prossimi mesi nuova spesa.
Le attuali quote di spesa e di impegni variano da regione a regione. In particolare, le regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) registrano una spesa che è mediamente minore della media nazionale (18% contro 23%).
L’analisi di questi dati consente di effettuare alcune considerazioni.
Sebbene l’avvio del ciclo di programmazione 2014-2020 sia stato lento e differito, nel corso del 2018 le regioni hanno accelerato l’attuazione finanziaria dei POR.
A parità di altre condizioni, questi risultati di spesa sono stati possibili perché dopo 25 anni di programmazione comunitaria le regioni hanno ben appreso come utilizzare il canale dei finanziamenti POR: è certamente accresciuta nel tempo la loro capacity building.
Essi, inoltre, rappresentano la base numerica per smentire l’errata percezione che le regioni italiane, e in particolare quelle del Mezzogiorno d’Italia, restituiscono all’UE le risorse comunitarie: si sta passando dal 23 al 30%.
Dunque, da uno studio sui bilanci di finanziamento, emerge un dato: che col tempo le regioni italiane stiano spendendo meglio e, quindi, ricevano di più rispetto al passato.
Certo, il dato del divario nord-sud è ancora evidente, ma di pochi punti percentuali. Va altresì evidenziato come siano sorte nuove professioni nell’ultimo decennio: esperti di rendicontazione, manager di progetto, dirigenti regionali addetti alle pratiche (oltre alle professioni nel campo delle comunicazioni che vengono coinvolte per la diffusione dei risultati di progetto).
La principale conclusione cui si può giungere, quindi, è la capacità delle regioni italiane di rispettare il timing della spesa e quella di creare nuove professioni che col tempo diventano sempre più necessarie per aumentare le performance italiane su questo tema.